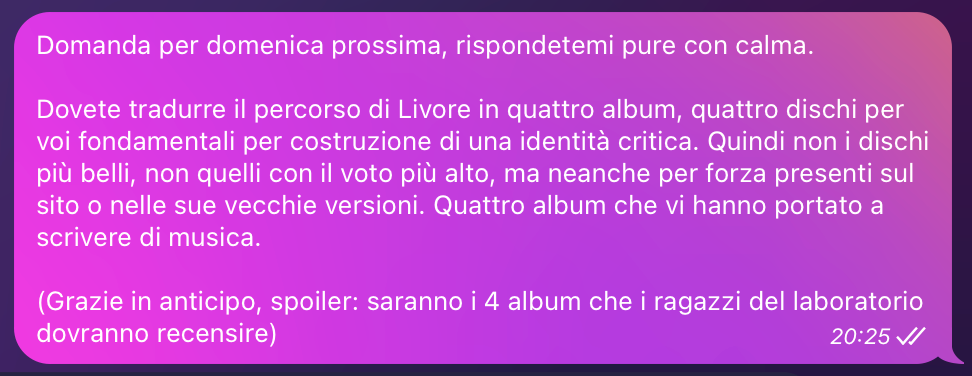Finora la nostra unica rubrica di recensioni è sempre uscita in occasione del laboratorio di giornalismo e mai più durante l’anno. Quando l’ho ideata stavo pensando a un modo per bilanciare le interviste: in un numero avremmo avuto la biografia dell’intervistato, in quello successivo quattro album fondamentali scelti da me che ne raccontassero la traiettoria artistica.
Stavolta però è stato diverso, perché non avevo un catalogo al quale fare riferimento, ma una webzine. Non come la nostra, una seria, importante, autorevole. Per questo dopo diverse opzioni tutte scartate ho contattato direttamente la redazione di Livore scrivendogli il seguente messaggio:
La loro scelta è stata un poker folle e inaspettato, mettendo in crisi i laboratoristi per ragioni diverse. Il risultato finale devo dire che è stato… sorprendente.
Buona lettura,
Giuseppe Di Lorenzo
¡El ingenioso flamenco de la Valencia!
Antología del cante flamenco heterodoxo
1- La paella è molto buona; 2- Miles Davis ha fatto “Sketches of Spain”; 3- Le corride sono una tradizione del cazzo. Questi tre punti grossomodo racchiudono quanto conosco e penso della storia, usi e costumi della Spagna - più o meno totalmente. Mi accingo comunque a discorrere di quest’opera, che proprio dalla suddetta Storia trae vita, per motivi che risulteranno chiari più avanti.
L’Antología qui trattata, il quinto disco di Francisco Contreras Molina ovvero in arte “el Niño de Elche” (cioè “il ragazzo da Elche”), si presenta come una corposa raccolta di canzoni spagnole, ma già il lunghissimo titolo suggerisce l’intento di evidenziare nel flamenco aspetti inusuali. Un flamenco heterodoxo appunto, perché quelle musiche evidentemente presentano già di per sé difformità col genere a cui appartengono, ma anche perché come vedremo el Niño di bizzarrie ne aggiunge parecchie. Molina non è nuovo a certe riletture poco ortodosse (e fortemente personali) del flamenco; a tal proposito si può ascoltare l’ottimo precedente dello sperimentale “Voces do extremo” (2015), in cui lo mischia ora con l’elettronica e le drum machines, ora con l’indie-rock. Ma quest’opera del 2018 non solo dura il doppio, ma taglia decisamente i ponti con l’aspetto commerciale della sua musica, a beneficio dell’originalità della proposta s’intende. Come possiamo noi avvicinarci a quest’opera programmaticamente tanto culturalmente stratificata e strutturalmente iconoclasta? Io propongo due possibili approcci.
Il primo è quello colto, metodologico. Il disco come detto racchiude in sé tutta una lunga tradizione di musica popolare spagnola, fatta peraltro di diversi sottogeneri, e richiederebbe parecchio studio per averne almeno una buona prospettiva storica. El Niño in questo ci viene incontro, perché ce li specifica già dal titolo delle canzoni, e tiene a scrivere sempre chi ne è l’autore. A tratti il disco procede infatti per fedeli riproposizioni, come in El tango de la Menegilda o nella Caña por pasodoble de Rafael Romero El Gallina. Ben presto però queste premesse vacillano per lasciare spazio a tracce sperimentali, estese, di grande impatto artistico. Un ottimo esempio già si trova nell’iniziale Soledades de la pereza, sospesa in un ambient trasognato con varie intrusioni rumoristiche, o anche nella lunga El prefacio a la Malagueña de El Mellizo, dove un solenne proclama viene sorretto da interminabili droni d’organo, a trasmettere un senso di religiosità. Al confronto, altri esperimenti sono talmente di rottura da sembrare fini a sé stessi.
La seconda traccia per esempio, Saetas de San Juan de la Cruz, priva di accompagnamento, è solo una voce riverberata che fluttua nel vuoto, mentre la quinta, Coplas mecánicas de Juan de Mairena, è una sequenza di campionamenti per nulla musicale; in questo genere di brani Molina e il produttore non si atteggiano mai davvero a compositori d’avanguardia, anzi giocano nello studio di registrazione come farebbero dei ragazzini. Appaiono qua e là persino recitativi puri, come il Recitando de Eugenio Noel.
Questo aspetto ludico, capriccioso della sua musica ha come doppio effetto quello di spiazzare l’ascoltatore che non sa mai cosa aspettarsi dalla traccia successiva, ma anche di risultare meno comunicativo presso il suo pubblico.
A scanso di equivoci, queste cose non sono propriamente dei pregi, sembrano indicare una mancanza di direzione di fondo, e facilmente si può argomentare che sostituendo questo tipo di tracce con altre riletture più strutturate l’opera ne avrebbe giovato in organicità e incisività - ammesso e non concesso che tali caratteristiche siano in sé dei pregi. Il produttore Raül Refree è un cervello fondamentale in quasi tutte le canzoni, la sua mano impegna tanto gli arrangiamenti tradizionali quanto i taglia e cuci più arditi, con sapienza ed esuberanza.
Secondo approccio, che poi è quello che consiglio. Come si è visto, conoscere le basi storiche del flamenco aiuta solo fino a un certo punto per capire quest’opera, e quindi tanto vale andarle incontro con fiducia e con coraggio. Assaporarla a pezzi, come un grosso, misterioso dolce con molti strati che vanno metabolizzati in varie serate.
Questo disco è anzitutto un profondo atto d’amore del Niño e di Refree nei confronti della propria terra, e un atto d’amore non va analizzato in modo troppo scientifico: si rischia di fiaccarne la poesia.
Molina è geloso della passione che ha reso ragione di vita, e perciò cerca di sgomberare il campo da ascoltatori casuali, per mezzo di scelte controintuitive, in chiaro contrasto con ogni logica commerciale. Ecco spiegato il perché di inserire fin da subito pezzi financo antimusicali; ecco perché decidono di rovinare la Rumba y bomba de Dolores Flores, una possibile hit elettropop che degenera inesorabilmente in un singhiozzo niente affatto divertente, presagio di guerra. “A chi non interessa, vada via!” sembrano dirci. Chi rimane troverà ricompensa nell’immane spazio stilistico coperto, dal pathos di pezzi folk come il lamento rivoltoso di Fandangos y canciones del exilio (nemmeno la politica è lasciata da parte) e la Saeta por seguiriyas de Manolo Caracol y Arturo Pavón, fino a omaggi a grandi personalità musicali dal mondo dell’avanguardia (Luigi Nono) a quello del pop (Tim Buckley); oltre che nelle prove vocali di straordinaria eterogeneità di questo consapevole Dr. Jekyll valenciano, che si dimostra fra i grandi interpreti del nostro tempo.
Il flamenco in senso lato già aveva subìto interpretazioni storicamente innovative nella cultura pop, a partire dalla seconda metà degli anni ‘70 (penso anzitutto al rock dei Veneno nell’esordio, o alla “La leyenda del tiempo” di Camarón); per non parlare di altri riusciti esperimenti che si sono susseguiti negli anni successivi. Ma il pantagruelico, post-moderno approccio del Niño in quest’opera resta un unicum, e si staglia fra le cose più memorabili accadute al genere negli ultimi vent’anni. La smaniosa ricerca costruttiva, il poderoso intreccio espressivo che sorreggono la “Antologìa” possono disorientare, ma essa resta innegabilmente un progetto ricco, emozionante, che stimola e provoca l’intelletto, e che incute un sano senso di soggezione.
Mi permetto infine la libertà di indicare il proverbiale elefante nella stanza, ossia che Molina prende anche spunto da tutta una (sorta di) tradizione di album doppi della cultura pop quali il “White Album”, “Trout Mask Replica”, “Physical Graffiti”, “Exile on Main St.” e così via. Tutti quei dischi insomma in cui un rinomato soggetto artistico (band o singolo non importa) si è trovato in un particolare, irripetibile stato di crisi o impeto creativo, e ha reagito buttando giù una serie di idee secondo magari un canovaccio di regia, ma senza una particolare direzione concettuale - nel bene e nel male certo, però comunque concretizzando un momento di storia. Lo sottolineo: Molina formalmente non compie un’azione molto diversa; ciò che i suddetti dischi fanno con il pop, il blues, il rock e folk angloamericani, lui lo fa con la tradizione popolare spagnola. Allora bisogna mettersi d’accordo, o in tutti questi casi ci si mostra grati verso chi ci rende partecipi del miracolo della musica e si apprezzano questi grandiosi sforzi compositivi anche se contengono qualche passo falso qua e là, o per coerenza anche questa Antología va criticata per gli stessi motivi.
Marco Ledri
Da 0 a Burial in due anni
L’ascesa di William Bevan
Ho scritto per la prima volta di Untrue di Burial il 27 novembre del 2007 (sì, sono andato a controllare). All’epoca rimasi estasiato da questo disco, un po’ come tutti, e ne scrissi con toni entusiastici. Quello che ancora non sapevo è che, a distanza di anni, quello che mi sembrava uno dei migliori dischi del 2007 sarebbe diventato, a dire di molti, uno dei migliori dischi di elettronica del decennio. E chissà se in questo secolo usciranno ancora album di elettronica così impattanti. Ma prima che tu possa pensare alla solita sparata, inquadriamo personaggio e contesto facendo un passo indietro, anzi due, perché è impossibile capire “Untrue” fuori dal suo contesto.
Nel marzo del 2005 un misterioso produttore noto come Burial fece il suo esordio nella scena musicale con l’EP “South London Boroughs”, pubblicato dall’etichetta Hyperdub. L’anno seguente gli stessi pezzi trovarono casa in “Burial” primo album omonimo del misterioso produttore.
L’album fu accolto con entusiasmo da pubblico e critica e addirittura incoronato «Album dell’Anno» da The Wire. Ricordo che ai tempi ero ancora abbonato al mensile cartaceo, che rivestiva per la mia generazione il ruolo che in seguito avrebbe avuto Pitchfork per i nativi digitali. Ad un certo punto si iniziò a parlare di Burial come del prossimo Aphex Twin: un ragazzo prodigio ai margini, destinato a influenzare il mainstream. Ben presto Burial squarciò il velo dell’anonimato rivelandosi come William Bevan, un giovane londinese del sud cresciuto a suon di drum’n’bass e garage degli anni Novanta.
Arriviamo così al 2007, a Untrue. Te lo voglio dire subito:
Untrue è come rimettere piede sul parquet di casa dopo una lunga passeggiata serale tra i capannoni industriali della Londra suburbana, dove il fango arriva a metà degli anfibi.
Non è certo musica per i precisini che tengono le babbucce di fianco al portone anche per gli ospiti. Sei pronto a sporcarti le mani, i piedi e tutto ciò che toccherai, compreso il tuo salottino ordinato? Partiamo dal titolo e dalla scelta di restare anonimo.
In quegli anni l’esposizione mediatica garantita dal digitale e amplificata da internet e dai primi social network, era ancora una novità: 10 anni prima internet non esisteva neppure! Appoggiarsi al web per raggiungere i propri 15 minuti di popolarità warholiani era una febbrile tentazione alla quale era difficile resistere per chi voleva raggiungere l’hype. Eppure Burial pubblicò il suo album di debutto rifiutandosi non solo di identificarsi, ma negandosi a fotografie e interviste contribuì ad accrescere la sua aura di mistero. Da ex blogger ricordo che si lasciava intervistare pochissimo e quello che usciva era particolarmente significativo. Una volta disse al critico australiano Anwen Crawford a proposito del titolo di “Untrue”:
«È come quando qualcuno non si comporta in modo fedele a se stesso. In questo modo si risulta stonati, come se qualcosa non andasse.»
Questa particolarità, unita al fatto che le sue opere uscivano sotto un moniker, suggeriva l’idea di una personalità fragile, all’inseguimento dell'autenticità ma che ancora aveva bisogno di ripararsi dietro ad uno scudo per esprimersi in libertà. Forse potrà sembrarti una lettura superficiale, ma non lo è. Nella musica strumentale (compresa quella elettronica), i titoli dei brani ricoprono un’importanza fondamentale, anche nell’esperienza dell’ascolto. Lo stesso vale per il titolo di un album. Ascolteresti nello stesso modo La cavalcata delle Valchirie se non sapessi che si intitola così?
All’epoca, mentre altri artisti dubstep intraprendevano un percorso di fredda alienazione, Bevan decise – non so quanto consapevolmente o d’istinto – di seguire una strada opposta, incendiando le emozioni attraverso campionamenti vocali, prevalentemente femminili e sonorità da videogiochi arcade.
Untrue arrivò sugli scaffali dei negozi (sì, allora c’erano ancora i negozi di dischi) meno elaborato, meno cerebrale, più genuino rispetto a come avevamo imparato a conoscerlo nei due anni precedenti. Le atmosfere erano decisamente più notturne, spaziali e ipnotiche. I bassi pesanti di Burial dipingevano paesaggi di una Londra industriale: le parti vocale campionate e deformate come plastica vinilica sciolta, artificiosità estetiche al rallentatore, nebulose primordiali sotto forma di elettronica ambient, scricchiolii della puntina sui solchi rovinati di un vecchio vinile. Tutto questo, sulle dita di un compositore dell’era elettronica.
Untrue è un disco carico di emotività, pervaso dal suono della pioggia e da synth spettrali, che restituiscono un quadro a olio di una Londra cupa e malinconica.
Non a caso pare che Burial testasse i demo ascoltandoli mentre guidava nella zona sud della sua città nel cuore della notte, a occhi chiusi (forse questa è una mia drammatizzazione), fingendo di trovarsi fra le zone post-industriali di Manchester.
Hai mai visto l’anime cyberpunk Ghost in the Shell? (se non l’hai visto, beh, dovresti) Ricordi la scena in cui Motoko Kusanagi si immerge di notte nell’oceano, tuffandosi all’indietro dal bordo della barca, ma metaforicamente verso l’ignoto? Ecco, “Untrue” è la sua colonna sonora ideale.
Francesco Piersimoni
IL SILENZIO,
LO SPARO,
LA SUA ECO.
“Third”, è un villaggio che sorge in mezzo al nulla, spettri di vento e polvere, scheletri di legno, circondati da una landa deserta indorata dal sole.
“Third”, è un western che vive e respira in un luogo metafisico, trasfigurazione onirica della campagna rurale inglese, Canterbury per l’esattezza, crocevia di uomini e di esperienze, binari che arrivano dal passato e puntano l’orizzonte nel tentativo di disegnare il futuro.
Epopea del progressive rock, roba per palati fini e spesso altezzosi, musica per infaticabili cacciatori che rincorrono prede altisonanti e sperano, con tutto il cuore, di non acciuffarle mai. Ricerca e istinto, movimento e libertà espressiva, arte racchiusa in dischi che qualcuno metterebbe volentieri nei musei, o appesi alle pareti dell’ufficio dello sceriffo con tanto di taglia in copertina. I pistoleri protagonisti di questa storia hanno volti giovani e già segnati dal tempo, dalle vecchie foto ingiallite ti guardano con espressione canaglia di chi ha costruito un recinto ai margini del mondo e non se n’è mai curato troppo, consapevole di aver scelto un mestiere molto poco affine alle tratte da bestiame del mercato musicale.
Tutto inizia nel 1960: un manipolo di musicisti con formazione classica e piglio intellettuale da media borghesia britannica si riunisce per conglobare esperienze e intuizioni artistiche, non sempre allineate. Cambiano formazione un’infinità di volte e solo dopo altrettanti ripensamenti scelgono di darsi per nome il titolo di un romanzo di quel folle visionario di William S. Burroughs. Pubblicano un primo disco, poi si sciolgono, poi si ritrovano, poi ne fanno un altro. Quando l’inquietudine sembra essere il crogiuolo più efficace per fondere le idee e lasciarle evolvere in musica.
È il 1970 l’anno in cui il gruppo si stabilizza (per poco) nella storica formazione a quattro che dà alla luce “Third”.
Hugh Hopper al basso, Mike Ratledge al pianoforte, Robert Wyatt suona la batteria e canta, quando glielo lasciano fare. Infine Elton Dean, sassofonista, ultimo arrivato a plasmare un equilibrio tanto felice quanto fragile.
C’è chi dice sia questo l’apice della storia musicale dei Soft Machine, ma come rintracciare la vetta in una produzione così ampia, articolata e mutevole?
Di certo, il loro terzo album, rappresenta un valido esempio dello stallo necessario a mantenere in equilibrio anime così eclettiche, visioni spesso diverse che, in quattro lunghe suite raccolte in un doppio vinile, sembrano trovare armonia in una, seppur fugace, coesistenza. Il fruscio della puntina che cavalca il suo solco nero che precede l’innescarsi di un duello.
Per i primi minuti le striature di un vecchio VHS graffiano le immagini nel fuoco di un mezzogiorno ricolmo di tensione, l’obiettivo si contorce, illuminando un innegabile scenario desertico ed è qui che, finalmente, arriva la cavalleria. Un tema epico si fa strada nella polvere, il ritmo in crescendo diventa sempre più serrato, gli strumenti a fiato intonano un riff irresistibile e dirompente: macchina di muscoli equini in proiezione, riflessi d’acciaio e sbuffi di vapore. Facelift, primo brano in scaletta, porta con sé la memoria di ciò che dovevano essere, all’epoca, i concerti dei Soft Machine. L’impasto musicale è oltremodo cinematico, pare di assistere a un montaggio di destrieri che galoppano in loop, continuamente e furiosamente; ripetuti saliscendi in cui ogni senso logico si smarrisce e resta solo, plasmato per sempre, lo spaesamento di chi esce sconfitto dall’assalto della fanteria.
Il generale Hopper dirige col suo basso, filtrato dalla luce elettrica del fuzz, e lascia andare i suoi compari a briglia sciolta per il loro andirivieni di battaglia, vien da sgranare gli occhi e chiedersi come diavolo facevano, a fare cose del genere, come potevano essere già oltre il prog, se questo era praticamente appena nato. C’è il flauto ad esempio, così come si usava e talvolta si abusava all’epoca ma, qui, la sua malia risuona come una maledizione, il graffio di una melodia che non lascia quiete, neanche negli attimi in cui solo apparentemente si riesce a respirare. Questa è la legge, straniero, questa è la vita e non ha alcuna trama, ci si affida all’improvvisazione, alla regola delle non regole, alla libera architettura delle note e agli intrecci dettati dall’istinto, questo è “Third”, col suo lento pigolare sul piatto, traccia dopo traccia.
Lentamente si allungano le ombre brune del tramonto, la nebbia si dirada, lasciando affiorare uno spirito che ha le sembianze di un miraggio: è il jazz, l’orizzonte verso cui è diretta l’intera carovana, una frontiera che ai tempi sembra per molti ancora impossibile.
Narra la leggenda che, a decodificare gli accordi di piano di Slightly All The Time, si possano trovare risposte a domande come: che cos’è, infine, l’amore? Mette imbarazzo, ritrovarsi al cospetto di una tale seduzione, ci si sente di colpo nudi e viene più volte voglia di fermarlo, quel disco da museo, prima che sveli troppo di tutto.
Ratledge, autore del brano con baffi da sicario, racconta storie maledette seduto al piano del saloon, portando per mano gli avventori oltre la finestra e a ognuno di loro stringe il cuore, coi suoi ostinati in bianco e nero, il basso gli fa da dama fedele, la danza scivola giù fino al deserto. Ciò che fa poi quella serpe di Dean è smuovere mulinelli di sabbia col luccicare dorato del suo sassofono, chissà se scorrono titoli di coda, se qualche amore finisce, in qualche straziante modo, da qualunque parte.
Malinconia, quanti invano hanno provato a raccontarla eppure raramente hanno osato metterci dentro tanto vitale tormento, l’ossessione di un ballo alla vita sghemba, contando un tempo ubriaco di sette su otto. Quando il ritmo si impenna il sole muore e a ognuno vien voglia di correre contro il tempo, è tardi fratello, è dannatamente tardi, per tutto. L’affiatamento fra i musicisti qui è impressionante, stratificazione del suono al rotoscopio, per immagini statiche il cui susseguirsi genera un eterno movimento, giù il cappello fratello, che siamo solo alla metà del viaggio.
Poi di colpo una voce, nel buio.
Così come un indiano solitario che senza motivo alcuno si mette a ululare alla luna arriva la prima (e unica) parte cantata di tutto il disco. Sarà forse anche per questo che lo scenario cambia, la parola introduce una nuova intimità, fatta di desiderio e dilemmi umani, così come il testo racconta. Se prima sembrava di assistere a un film, innegabilmente coinvolgente, ora pare piuttosto di esserci finiti dentro, di sentire quella voce che punzecchia i propri tormenti proprio qui accanto, accompagnata da un ritmo quasi capriccioso.
In uno scenario tanto bizzarro spicca il dramma che accompagna la storia di Moon In June, terzo capitolo in scaletta a firma di Wyatt. Ratledge e Hopper, poco convinti dalle potenzialità del brano, si rifiutano di partecipare alle sessioni di registrazione, limitandosi a qualche sparuto intervento, lasciando in sostanza solo il batterista che, facendo il broncio, si vendicherà mettendo le basi per una carriera solista che lo porterà a essere uno dei musicisti più apprezzati della sua epoca.
Ma questo è il west, un’epoca selvaggia in cui i musicisti facevano anche cose del genere e i duelli si risolvevano a colpi di capolavori.
Moon in june è semplicemente pazzesca, contiene almeno cinquanta idee e tutte sono giuste, armoniosamente raccolte in un’unica sontuosa composizione che riesci perfino a canticchiare ma che risulta quasi impossibile da replicare. E’ anarchia musicale allo stato puro, apparentemente più comprensibile degli altri brani, segue dei saliscendi armonici che a un primo ascolto risultano addirittura fastidiosi, ma che diamine fa? Dove sta andando? La smarrisci e poi la ritrovi in frammenti improvvisamente commoventi che non smetteranno più di tormentarti. Lascia solo un indiano e quello invocherà certi spiriti da far spavento, farà le beffe al generale, ruberà le tastiere al sicario e le userà per scatenare una tempesta, inquietante e irrisoria. Ecco chi è Wyatt, un piccolo demone, saltella sui ritmi forsennati attorno al proprio fuoco e, anche se ne hai paura, anche se non lo capisci fino in fondo non puoi che restarne ammaliato, mentre i suoi gorgheggi si perdono nel buio.
Quando il sole torna a sorgere è grande la sorpresa di aprire gli occhi e ritrovarsi in un posto completamente diverso. Out-Bloody-Rageous, ultima storia in programma, raccoglie quanto accaduto per condurci verso il domani. La stessa eleganza della seconda traccia, la medesima frenesia del brano iniziale solo che, qui, al posto dei cavalli in corsa troviamo i “cabs” impilati nel traffico quotidiano della dolce Londra. Si sbattono gli occhi più volte, increduli, senza riuscire a capire se questo è il risveglio alla fine del sogno o se invece è una visione del futuro emersa dai fumi di un rito sioux, in un finale in cui è possibile addirittura intravedere l’arrogante aristocrazia del jazz elettronico che, per un disco “rock” del 1970, è quasi eresia.
Scolpito dal vento resta il testamento di un disco che per quasi ottanta minuti si limita a fare una cosa sola: celebrare l’importanza del gesto e il significato atemporale del suono. Come un pistolero, che immobile scruta il silenzio, in attesa dell’unico attimo possibile in cui afferrare la pistola e spezzare il mondo con uno sparo, per poi affidare alla sua eco il riecheggiare della propria leggenda, così fa un musicista, maneggiando pause, note e riverberi in un’unica azione, ripetuta un’infinità di volte, una cosa che è solo cuore e istinto, forse pazzia, una faccenda evidentemente personale, come un vecchio conto da risolvere, tra lui e la storia.
Affrontare, oggi, un monolite roccioso come “Third” può causare il mal di testa, questo è innegabile. La sua piena fruizione richiede un tempo e una disponibilità di pensiero che sembrano sempre più inconsueti, nel nuovo west dei giorni moderni. Eppure forse è proprio questa la sfida che ancora offre, la sovversione delle tendenze, lo sforzo della bellezza, la ricerca di attimi di pausa da tutto per riempirli con l’esperienza. Organizzare serate di ascolto collettivo, stappando magari una buona bottiglia, affrontando i musicisti pistoleri in un duello di pensieri, di immagini, di idee nuove che neanche loro sapevano di aver messo in questo disco perché, quella di “Third”, è musica in movimento e non può stare ferma, non lo ha mai fatto e non lo farà mai.
Alessio Esposito
Analisi di un diverbio: L’atto finale dei Daft Punk
Conoscete la storia di quel recensore paraculo che non ha ancora capito se “RAM” è una pietra angolare della musica degli anni dieci o una vera ciofeca? Si narra che per chiarirsi le idee si fece aiutare dalla sua doppia coscienza: un diavolo seduto su una spalla e un angelo sull’altra.
Recensore: Datemi una mano per il Laboratorio, devo recensire “RAM”!
Diavolo: Quello del Macca? Daje.
Angelo: Quello dei Daft Punk.
D: Ah…
R: Partiamo dall’inizio: era il 2013, avevamo 18 anni e i parigini fecero uscire il loro quarto LP “Random Access Memories”. Io lo ricordo in tutte le classifiche mondiali e osannato dalla critica, ma come l’ha vissuto l’adolescente che ero?
D: Terribilmente, volevi evitarlo come la peste ma ci sei finito in pieno quando ti sei sorbito l’onnipresente Instant Crush la prima volta che l’hai fatto. Bravo, sei stato segnato a vita con una canzone di merda.
A: Magnificamente, ti ricordi l’epifania quando hai sentito per la prima volta Giorgio by Moroder in macchinata nel pre-serata?
R: Non state aiutando, parlatemi piuttosto dell’album.
A: Vuoi dire il monolite della disco music! Immaginati i dandy che all’apice del successo decidono di puntare ancora più in alto. Si mettono al lavoro per quasi cinque anni, investono una montagna di soldi ed elaborano un magnifico omaggio alla musica di un periodo ben preciso (fine settanta, alba degli ottanta), così studiato da avere la tracklist pronta anni prima dell’uscita del disco. Ed è concepito proprio come un album dell’epoca, da ascoltare dall’inizio alla fine: il VERO album dei Daft Punk! Adori il sound che spazia tra il pop degli Steeley Dan e dei Supertramp alle colonne sonore zeppe di synth a la Vangelis, con momenti progressive che puoi addirittura ballare, l’avresti mai detto?
D: Ma se ti rompi i coglioni per 75 minuti buoni! Tutto l’album è ridotto ad un funky basso bello potente (e ci mancherebbe), chitarra chicken scratch perché Rodgers evidentemente sa suonarla solo così, qualche nota fintamente improvvisata su un Fender Rhodes e voci filtrate dal vocoder. La sostanza è tutta qui, il resto è un’accozzaglia di idee buttate alla rinfusa e messe insieme sotto una patina da disco-music. E sai bene quanto la disco ti faccia schifo.
A: Ricordati che Get Lucky è uno dei pochi brani che ti fa muovere quel culo flaccido. E non è manco l’unica hit.
D: l’altra qual è? Lose Yourself to Dance? La prima è una parodia di una canzone degli Chic (hanno proprio pescato bene tra le influenze sti due), la seconda è la parodia della prima. Bene così.
A: Ma che parodia, ci sarà pure la mente degli Chic ma il risultato sta su un altro pianeta! Get Lucky ha cambiato i connotati del pop: prima del 2013 manco Bruno Mars sapeva cosa fosse il funk, hai visto cos’è successo dopo?
R: Okok, avete tirato fuori un tema interessante: le collaborazioni?
A: Thomas e Guy-Man sono guidati dalla nostalgia (del futuro, direbbe qualcuno): chiamano vecchi collaboratori (Todd Edwards, fidelis raro dai tempi di “Homework”, e Chilly Gonzalez) e omaggiano i loro eroi del passato (Giorgio Moroder e Paul Williams) e del presente (Julian Casablancas e Noah Lennox). Poi, come sempre è stato fatto nelle hit disco, usano la “voce del momento”, una Donna Summers con un filino di carisma in meno: Pharrell Williams.
D: E meno male! Ti ricorderei anche che in quelle che tu chiami collaborazioni Panda Bear presta soltanto la voce e Julian Casablancas suona un assolo. Il mondo al contrario.
R: E la copertina? Cosa vi racconta?
A: Il primo degli omaggi: il font usato è quello di “Thriller”. E per un titolo perfetto a rappresentare una capsula temporale che ti riporta agli albori della musica elettronica. I Daft Punk concludono un ciclo…
D: Bella presa di posizione…Hanno nascosto il logo, ogni volta diverso ma così identitario della loro musica, e l’hanno sostituito con il simbolo del loro anonimato. Mossa atroce.
R: Ma… mi state suggerendo che nella discografia dei Daft Punk, “RAM” per uno di voi è un elemento di continuità mentre per l’altro di rottura?
D: Ma è evidente! Sono passati ad un equipaggiamento più analogico e a veri strumenti, riducendo i campionamenti (LE BASI CAZZO) al minimo storico, e coinvolgendo un centinaio di musicisti (che sanno suonare) e quasi una decina di persone in regia. Risultato? L’album più umano del duo suona come il più algido. In fin dei conti io ci vedo solo due musicisti poco talentuosi ma con un gran gusto nel farsi guidare da colossi industriali (discografici o di alta moda, ma che importa?) per continuare a fare la loro merda senza metterci la faccia. Un mero. Prodotto. Commerciale.
A: Madonna, ancora con sta storia del commerciale… Da sempre i Daft Punk sono stati fedeli ad un sound, a prescindere da come veniva raggiunto. Pure in “Discovery” fanno uso di una strumentazione meno elettronica e ci buttano la disco music, sveglia! È il loro modo di connettersi con quello che hanno sempre amato, una musica che risplende nella high fidelity che per anni è stata dimenticata per colpa dei walkman di merda. “RAM” non solo rappresenta un elemento di continuità nella loro discografia, ma il degno finale.
D: Guarda che il vero finale è avvenuto fuori tempo massimo, quando Thomas doveva farsi esplodere perché era troppo impegnato con Bach e i balletti russi.
A: Ma infatti quel video è musicato con un inedito di Touch, che chiude l’album in questione.
R: Va beh va beh, giù le mani! Non divaghiamo con quello che è successo dopo, ditemi la traccia migliore e chiudiamo.
D: La meno peggio? Ti direi Motherboard, almeno creano qualcosina che non assomiglia ai Daft Punk ma ai cuginetti Air.
A: Scusa eh, ma vorrei ricordarti l’emblema del disco: Giorgio By Moroder. Stiamo parlando di un sentito omaggio a un’artista che ha plasmato il suono di “RAM”, e i Daft Punk lo fanno con la sua voce non alterata (ok, va bene, non tanto alterata), con la sua storia non romanzata. Stanno creando di fronte a noi una delle più belle colonne sonore mai scritte, perché il film ce lo stiamo proiettando in testa, scena dopo scena. Per questo è la perfetta traccia da ascoltare in movimento, è il degno epigono della Chase moroderiana da cui non solo hanno preso tutta l’arte, ma pure l’autore. E nonostante i picchi di pathos sono numerosi nell’album (Touch e Contact ne contengono di notevoli) l’arpeggio pazzesco del moog, gli scratch, i grossi break di batteria, l’assolo di basso e un sequencer che non è mai stato coniugato così bene con un’orchestra formano un crescendo senza rivali. Pura magniloquenza? Come un certo Michelangelo al Campidoglio.
Segue una lunga pausa riflessiva dopo la quale i due esserini, accorgendosi di stare scomparendo, concludono all’unisono:
D: Non vorrei ripetermi, ma: troppa forma per poca sostanza riciclata, “RAM” è uno stomachevole millefoglie industriale. Perchè non proponi alla Treccani di citarlo sotto la definizione di “patinato”?
A: Per la qualità della produzione, RAM siede accanto al prisma dei Pink Floyd, a “Rumors” dei Fleetwood Mac e al glamour degli Steely Dan. Ir-rag-giun-gi-bi-le.
A quel punto il recensore si mise le mani nei capelli, gli sembrò di avere le idee più confuse di prima! Contò un’ultima volta i caratteri dell’articolo, lo mise in allegato alla mail per il caporedattore e incrociò le dita…
Emiliano Manni
Non vi abituate male, il prossimo sarà il penultimo appuntamento con i numeri speciali del laboratorio, da febbraio torneremo con la programmazione mensile, assieme a qualche piccola sorpresa durante l’anno.
Grazie per essere arrivati fin qui, ci leggiamo domenica prossima!